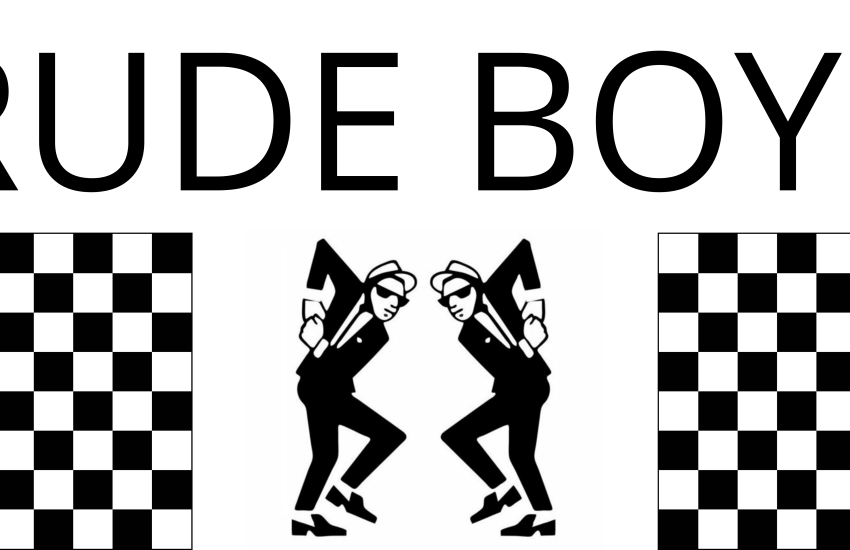BEAT – “The British Invasion” –
“Beat, beat, beat, beat” ed è subito “ritmo, ritmooo”, come direbbe il Maestro Canello al cenone di Capodanno. “To Beat”, infatti, significa battere (quello della batteria, maliziosi).
Nasce dalle ceneri dello stile chitarristico alla Chuck Berry e del midtempo di artisti come Buddy Holly. Dentro al beat c’è anche un pochino di swing, di blues e di parti cantate in stile doo-wop. Negli anni ’60, ovunque ti girassi, c’erano gruppi Beat ad esibirsi nei locali. In seguito al concerto dei Beatles del 4 novembre 1963 al cospetto della Regina madre, i media di tutto il mondo iniziano a parlare del nuovo fenomeno musicale e commerciale, tanto che una parte dei media statunitensi utilizzarono per la prima volta il termine “Beatlesmania“.
Il Beat arriverà, quindi, anche in Italia. Locali come il Paip’s a Genova e a Milano, La Perla a Torino, il Piper (LA STORIA) e il Kilt a Roma, La Mela a Napoli, danno visibilità ai gruppi Beat del momento.
Gli adoratissssimi Equipe 84, i Pooh, i Nomadi (tanto amore) I Camaleonti, i Dik Dik, i Gens, i Corvi. Sono solo alcuni dei complessi musicali destinati ad incidere brani che entreranno a far parte per sempre della nostra storia musicale, spesso raggiungendo il successo grazie al Cantagiro. Alcuni di loro iniziano facendo Beat, ma poi muteranno, cresceranno e comporranno Progressive come Le Orme e i miei amati New Trolls (ah, Concerto Grosso): “I Ribelli” che prima facevano Beat, diventeranno gli “Area” (sempre con il mio love Demetrio Stratos alla voce) i “Quelli” cambieranno in “PFM”, i “Volti di Pietra” si chiameranno “Osanna” (ah, Milano Calibro 9), i “Battitori Selvaggi” subiranno la metamorfosi in “Balletto di Bronzo” (ah, Sirio 2222). Insomma, ci sarà da ridere quando parlerò del Prog italiano. Li amo tutti.
Comunque se fossi nata qualche decennio fa nel Regno Unito non sarei stata una serata in casa. Avrei preso la residenza al Cavern Club, tra birrette e musica live suonata da gruppetti di adolescenti con pruriti ormonali: Beatles, Rolling Stones, The Who, The Kinks, The Yardbirds. Insomma, due complessi musicali qualsiasi.

In quel periodo c’è stata una vera invasione britannica, tant’è che questo lasso di tempo tra il 1964 e il 1967 verrà denominato “British Invasion“. Voce, chitarra, basso elettrico, batteria e poche musse, si va dritti al cuore e ai padiglioni auricolari degli ascoltatori.
Nel Beat si batte sulla seconda e quarta battuta, ma spesso guidando l’enfasi verso tutte le battute del 4/4 (se ripeti questa frase velocemente ti si attorciglia la lingua). Questo ritmo, chiamato “mach schau” (make show), inizia ad essere usato a dismisura nei club tedeschi di Amburgo, dove molti complessini di fanciulli sbarbatelli si esibiscono. Quei fuoriclasse dei Beatles stanno un bel po’ in tournèe in Germania, dove crescono musicalmente, per poi tornare a Liverpool cambiati esteticamente (con il loro taglio a scodella e vestiti da bravi ragazzi) e musicalmente.
A Liverpool c’è del gran fermento: ci sono circa 350 gruppi musicali che si esibiscono nelle balere e nei club. Giovani adolescenti e signori attempati si accalcano nei locali.
L’assenza di Stato sociale, il declino industriale e la presenza di un porto, che rappresenta il miglior punto di accesso di dischi e strumenti americani, fanno di Liverpool un luogo di riferimento per i giovani interessati alla musica e alle novità.
Dal 1962 iniziano a suonare in giro gli sconosciuti Beatles. Partono eseguendo brani di genere Merseybeat: chiamato così per distinguere geograficamente il Beat originario di Liverpool, in quanto Mersey è il fiume che scorre nella città. In Italia, invece, si diffonde il Bacchiglionebeat, in onore al fiume che scorre a Padova.
Qualche km più in là, a Birmingham, si forma lo Spencer Davis Group con un giovanissimo e minorenne Stevie Winwood dalla voce potentissima e che anni dopo fonderà i Traffic. A Newcastle gli Animals di Eric Burdon, a Belfast i Them di Van Morrison. A Tottenham the Rolling Stones, the Kinks e the Yardbirds. Che sballo. Che tempi. Porcaccia la miseria.

Nel 1964 i Beatles sbarcano in America, suonano all’Ed Sullivan Show e da lì comincia il monopolio FabFouriano delle classifiche statunitensi. I 4 noti scarafaggi prendono a braccetto gli altri gruppi del Regno Unito e se li portano appresso lungo la strada del successo: Rolling Stones, Kinks, Troggs e Animals.

Sentite ragazzi, io non me la sento di sbattere i Beatles in questo articolo. Meritano una robina a parte, assieme ai Rolling Stones e agli Who.
Vi parlerò di Kinks e di Animals, che spaziano ugualmente oltremodo.
THE KINKS
I fratelli-coltelli Ray e Dave Davies sono i primi Gallagher Bros. Tipo Caino e Abele. Ah, la famigghia. Nascono nei sobborghi a nord di Londra, suonano la chitarra e ci vanno sotto con il R’n’R. A scuola formano una band, il “Ray Davies Quartet”, insieme all’amico e compagno di classe di Ray, Pete Quaife, e a John Start. Si esibiscono durante il ballo scolastico e, come accade nei classici teen-drama, iniziano a farsi strada nei club della zona. C’è un turnover di cantanti solisti: per un certo periodo, tiene il microfono in mano anche Rod Stewart, ma poi esce dal gruppo come Frusciante e crea un altro complessino. Ray Davies & Co cambiano il nome in Ravens e assumono il promoter dei Beatles per pianificare la tournée. Cioè, mica uno pigliato a casaccio.
Niente, i ragazzi non hanno quiete e cambiano nuovamente il nome, questa volta definitivo, in “The Kinks”. Ci siamo. Ma che vuol dire? Secondo il critico musicale, giornalista e conduttore radiofonico britannico Jon Savage:
“[Loro] avevano bisogno di qualche cosa che attirasse l’attenzione su di loro. Quindi, “kinkiness” (devianza), da kinky, termine inglese molto usato all’inizio degli anni sessanta, che indicava un modo eccentrico di essere e di vestire, qualcosa di cattivo ma al limite dell’accettabilità. Nell’adottare “Kinks” come loro nome in quel momento, stavano partecipando al rituale pop dell’epoca di ottenere la celebrità attraverso l’oltraggio”.
Ray Davies ricorda come il nome della band fu coniato da Larry Page, in riferimento al loro eccentrico (“kinky”) senso della moda.

Nel 1964 durante una discussione furiosa tra i fratelli Davies, Dave in un impeto di rabbia taglia il cono del suo amplificatore Elpico con la lama di un rasoio e cerca di porre rimedio unendolo con una spilla da balia. Ciò che esce fuori dall’ampli è un ‘fuzz’ aggressivo e potente: il suono ideale per il riff di “You Really Got Me”. Siccome Dave non vuole nemmeno dare la soddisfazione al fratello Ray di aver in qualche modo contribuito alla nascita di quel suono innovativo, distorto e rivoluzionario, sosterrà:
“Ray non c’entra niente, non stavo litigando con lui. Ero da solo in una stanza al 6 di Denmark Terrace a Londra quando mi sono arrabbiato perché mi ero lasciato con la mia ragazza. Ho tagliato il cono dell’amplificatore del rasoio in un impeto di rabbia. Ray non era con me, ero da solo con la mia rabbia”.
Quindi esce il terzo singolo, “You Really Got Me”, che si catapulta subito in cima alla classifica della Gran Bretagna. Nei campus studenteschi ‘sto brano diventa un tormentone. Ci credo, con quel riff e quelle voci sguaiate. In pratica, con questo pezzo, i Kinks hanno imbracciato una pala, hanno scavato nella terra fertile…e lì hanno riposto i semi del punk, dell’hard rock e del metal. Stessa cosa per il singolo successivo, ossia “All Day and All of the Night“, con quella chitarra acida che anticipa il garage e il rock un po’ più granitico; arriva l’assolo e ti viene da accennare un headbanging, premonitore di un sound futuro. I Kinks fanno del Beat aggressivo.
Il 19 maggio al Capitol Theatre di Cardiff si svolge un loro concerto che finisce per trasformarsi nella rissa da saloon tipica in cui Bud Spencer, con una biccellata, fa rotolare lungo per terra il malcapitato. Davies insulta Avory e molla un calcio alla sua batteria. Avory si alza e, con nonchalance, gli molla un cartone che lo manda KO. Privo di sensi lo trascinano giù dal palco, come un sacco di patate.
Cercano di metterci una pezza, dicendo “Oh raga, tranzolli, era tutta una scenetta programmata”. Nessuno se la beve. Anzi, la American Federation of Musicians non concede loro il permesso di esibirsi su suolo statunitense per i successivi quattro anni. Poco male, se ne vanno a suonare in India, a Bombay, dove sperimentano strumenti e suoni nuovi. Nel ’65 esce “See My Friends” e si sente un sacco di Indian Style, anni prima dell’uscita di “Norwegian wood” dei Beatles.
Qualche anno dopo Quaife, il bassista, dice ai compagni di avventura: “Ciao gioie, io quasi quasi vado via dalla band” e gli altri, all’unisono, rispondono “Ahahahahah, sei troppo simpa, cioè, troppo ridere davvero”. Qualche giorno dopo, uno dei Kinks, compra la rivista NME (tuttora in produzione: fighissimo) dal giornalaio e legge un nuovo articolo, nel quale si parla di Quaife e del suo nuovo gruppo, i Maple Oak. Ah, allora non scherzava. C’aveva pure il piano B,’stostrunz.
Rimpiazzato Quaife, Ray Davies va all’ American Federation of Musicians e chiede di poter tornare a suonare in America. Affare fatto. Prima di cominciare una tournée nella terra di Zio Sam, i Kinks registrano l’opera rock “Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire)”. È un musical che narra la storia di Arthur, il cognato dei Davies Brothers emigrato in Australia con la loro sorella. Nessuno se lo fila di pezza. A distanza di anni la gente lo osanna e sostiene che sia un capolavoro quasi più bello di “Tommy” degli Who. Si, ma state calmi.
I riflettori si riaccendono sui Kinks quando viene pubblicata la canzone “Lola”, che narra di un giovane sedotto da un travestito. Non c’è volgare ironia, non c’è giudizio, c’è semplicemente una scena da descrivere:
“Well I’m not the world’s most masculine man, but I know what I am, I’m a man, and so is Lola”.
Questa canzone anticipa il Glam, le storie narrate da Lou Reed, Marc Bolan, David Bowie.
Insomma, i Kinks sono passati troppo in sordina: hanno predetto il futuro rielaborando il passato. Ascoltate “Superman” ad occhi chiusi e immaginate i Franz Ferdinand.
C’è addirittura chi sostiene che in “Preservation” siano presenti i prodromi di “The Wall” dei Pink Floyd.
THE ANIMALS
Eric Burdon ha una delle voci che più mi fa impazzire in assoluto. Voce black, blues nella struttura delle sue cellule, grinta da vendere. Assieme al tastierista Alan Price, al bassista Bryan “Chas” Chandler al batterista John Steel e al chitarrista Hilton Valentine decidono di chiamarsi “The Animals”. Si, perché sul palcoscenico sono degli animali. Appassionati di Blues, suonano con il famoso bluesman Sonny Boy Williamson, a Newcastle. Tutto documentato nel 33 giri “The Animals With Sonny Boy Williamson”.
Incidono una nuova versione del traditional “The House Of The Rising Sun” e, così facendo, si fanno conoscere per il globo. È il mio cavallo di battaglia, quel brano che potrei cantare anche con il mal di gola e l’afonia. Ebbene si, un tempo cantavo…e pure bene (a detta degli altri). È un pezzo lineare che ti arriva dritto nella pancia; chi lo canta non ha bisogno di avere venti ottave di estensione vocale, ma di un timbro originale, un pizzico di black groove e tonnellate di grinta.
“Boom Boom” di John Lee Hooker, “Around and Around” di Chuck Berry, “I’ve Been Around” di Fats Domino, “Bring It On Home” di Sam Cooke sono solo alcune cover che registrano gli Animals per far capire quanto cacchio amassero la musica nera.
I miei animaletti preferiti incidono “We’ve Gotta Get Out Of This Place”: il giro di basso ipnotizzante, il tintinnio dei piatti della batteria, poi la voce calda e bassa di Burdon, subentra la chitarra, poi le tastiere…e la voce si alza nel volume e nella tonalità. Il ritornello è leggero. Io boh, ritorno all’adolescenza quando andavo alle feste nei locali di nicchia genovesi, dove mettevano ancora i 45 giri sui piatti dei giradischi. Uno di questi posticini belli era lo Zerodieci (come il prefisso telefonico di Zena). Gente ben vestita, mods, modette e skinheads. Parte del mio Universo.
Altra pietra miliare è “It’s My Life” con il sound acidulo delle sei corde che si mischia a quello pastoso e caldo del basso. In pratica Burdon ci canta:
“It’s my life and i’ll di what I want, It’ s my mind and i think what i want”
Ci mancherebbe altro, Eric.